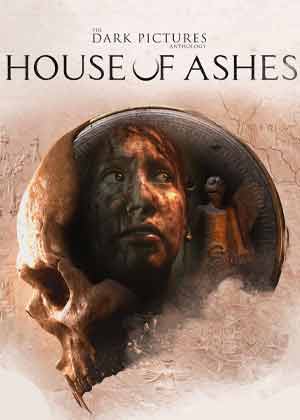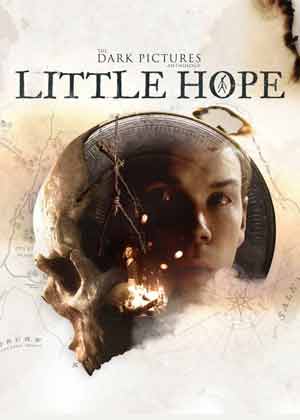Con il quarto capitolo, la prima stagione di The Dark Pictures Anthology sviluppata da Supermassive Games trova la sua conclusione. The Devil in Me chiude un percorso fatto di alti e bassi, durante il quale gli sviluppatori hanno voluto, lodevolmente, cimentarsi con diversi tipi di paura, generi horror, scenari e leggende di sorta; non tutti hanno colpito nel segno ed è stata sicuramente una graduale evoluzione che li ha portati a limare gli spigoli più grezzi fino a quest’ultima discesa nell’incubo, una storia sospesa fra thriller e horror che pizzica da saghe note quali Saw e Hostel partendo (com’è poi stato con Little Hope) da una base tristemente vera.
Il gioco è basato sul primo, e forse peggiore, serial killer americano, Henry Howard Holmes: mente brillante quanto deviata, Holmes è vissuto nel 1800 (1861-1896) e ha ucciso più persone di quante gliene siano state imputate. Famigerato per la costruzione del cosiddetto Castello della Morte, un edificio adibito a hotel che in realtà era soltanto una trappola mortale per le sue ignare vittime, verrà condannato alla forca a trentacinque anni. Le sue vicende hanno ispirato gli sviluppatori nel dare vita a un capitolo complessivamente molto meno prevedibile dei precedenti e più avvincente, anche in virtù di personaggi ben amalgamati tra loro.
Dopo dodici ore passate a sopravvivere a ogni possibile “trabocchetto” di un nuovo ma non meno letale Castello della Morte, sono pronta a parlarvi dell’esperienza completa di The Devil in Me su PC.
Ciak si muore!
L’incipit narrativo di The Devil in Me ruota attorno alla troupe della Lonnit Entertainment, cinque persone che si occupano di girare un documentario incentrato sui serial killer e vengono invitate da un tale Granthem Du’Met nella ricostruzione del Castello della Morte di Holmes – su cui si incentra, per l’appunto, l’ultimo e possibilmente fortunato episodio.
Pare infatti che lo studio non navighi in ottime acque, perciò l’opportunità offerta da Du’Met, sebbene bizzarra in alcuni aspetti, viene subito colta dal proprietario Charles Lonnit.
Assieme al cameraman Mark, alla tecnica delle luci Jamie, all’ingegnera del suono Erin e alla presentatrice Kate si reca dunque sull’isola dove sorge l’edificio. Il gruppo imparerà molto presto che, nella sua raffinatezza, la ricostruzione del Castello della Morte ha uno scopo preciso: fare di tutti loro le prossime vittime, sotto la direzione di un misterioso assassino.
Si ribaltano i ruoli e i membri della troupe diventano gli inconsapevoli attori, o forse sarebbe meglio dire le marionette, della figura che si aggira lungo i corridoi e regola ogni aspetto dell’hotel, regista e burattinaio di una strage premeditata che starà a noi sventare.
Ognuno dei personaggi, come siamo stati abituati con i precedenti capitoli, ha una sua personalità i cui tratti emergono in base al modo in cui li faremo reagire agli eventi ma soprattutto interagire fra loro: l’eventuale animosità tra alcuni di essi non ha ripercussioni sugli eventi, a quanto pare questo è destinato a rimanere un unicum nella storia di Supermassive con Until Dawn – un peccato, da un certo punto di vista, perché resta uno dei migliori colpi di scena ai quali mi sia mai capitato di assistere.
Ad ogni modo, l’importante è che non siano messi in scena dei cliché su due gambe e per fortuna non succede: che si amino o si odino, i nostri sfortunati protagonisti sono sfaccettati a sufficienza per essere ben definiti senza scivolare in un’eccessiva e inutile caratterizzazione. Detta così, per un gioco che è soprattutto narrativo, può sembrare un’eresia ma dato il genere è necessario non allungare troppo un brodo che già occupa tra le otto e le dieci ore: non ci interessano dettagli che sarebbero fuori fuoco, ne bastano pochi e mirati.

Sappiamo dunque che Charles è un fumatore incallito, che Erin soffre d’asma, che Kate crede o, quantomeno, si affida al misticismo, che Mark soffre di acrofobia (paura delle altezze) e Jamie è una testa calda più tendente all’azione che al pensiero. Dettagli apparentemente ininfluenti ma in realtà avranno un loro posto nella trama, assieme ad altri che non vi dirò per non rovinarvi la sorpresa. Non tutti vengono sfruttati a dovere, o non lo sono stati nella mia partita, e forse non avrebbe guastato se ci fosse stata più dedizione in merito ma a parte questo è un cast che funziona.
Soprattutto, non c’è stato questa volta alcun episodio di uncanny valley come invece si è sentito, pesantemente, in House of Ashes: Charles è il mocap meglio riuscito, questo però non toglie merito a tutti gli altri che offrono espressioni convincenti e in generale non sembrano dei pesci fuor d’acqua.
Si sente anche molto meno l’enfasi sul multigiocatore che, nei capitoli precedenti, emergeva prepotente con lunghe pause da parte dei PNG prima di risponderci o reagire a un nostro comportamento. Qui c’è molta più immediatezza, un livello simile a quanto visto in The Quarry, il che concorre a rendere le interazioni credibili e genuine – complice il fatto di avere i personaggi spesso separati. Meno interazioni uno a uno, meno rischi di finire in situazioni dove l’interlocutore sembra non sapere perché sia al mondo.
Il vero punto di forza di The Devil in Me sul profilo narrativo è il suo essere un thriller-horror, nonché l’aver puntato su una persona realmente esistita: in questo modo riesce difficile anticipare gli eventi e reagire di conseguenza, com’è stato ad esempio in Man of Medan dove conoscere la leggenda alla base era sufficiente per non farsi ingannare da nessuna delle mostruosità in gioco. Qui siamo contro un presunto emule di Holmes, o forse lui stesso redivivo, capace di trovarsi sempre alle nostre spalle ed essere lui, questa volta, ad anticipare ogni nostra mossa costringendoci a pensare rapidamente su come reagire e di farlo uscendo dagli schemi, perché non sempre la soluzione più logica è la migliore.
Alla componente thriller, che emerge soprattutto nel cercare di scoprire chi sia l’assassino grazie a tutti gli indizi sparsi nel gioco, si affianca l’immancabile horror, nel caso specifico il body-horror. Non saranno grottesche visioni alla Scorn ma questo non vuol dire che quanto rappresentato qui sia da meno, soprattutto appena iniziamo a connettere i vari tasselli. Il team non si risparmia nel mostrarci fino a che punto possa spingersi l’assassino, sebbene a volte la sola suggestione faccia molto più del dettaglio macabro.

Molto apprezzabile infine, e già l’abbiamo visto in House of Ashes, il modo in cui vengono ricostruiti eventi passati attraverso intere sequenze narrative doppiate affiancate da video o immagini in bianco e nero: delineano personaggi che non ci sono più senza bisogno di farli vedere.
A proposito del passato, come già accaduto con i precedenti giochi anche in questo caso siamo messi di fronte all’orrore in essere: interpreteremo quindi due delle vittime di Holmes e vedremo lui stesso in carne e ossa, per una interpretazione breve ma a mio avviso di valore nel dipingerne l’inquietante figura.
Nel complesso, ancora una volta The Dark Pictures Anthology tiene a fede ai suoi propositi: offrire un’esperienza plasmata dalle decisioni del giocatore, che segue gli schemi dei generi horror ma non racconta (meno che mai in questo caso) storie dell’orrore. Non sono, insomma, avventure fini a loro stesse ma l’evoluzione su larga scala dei libri-game, dove anziché controllare solo un personaggio abbiamo la responsabilità di un intero gruppo con tutto ciò che ne consegue.
La cosa più difficile da fare, ed è come secondo me questi giochi andrebbero giocati, è essere fedeli alla caratterizzazione del personaggio e ad eventuali derive che le nostre scelte fanno prendere loro: non pensare a cosa faremmo noi, perché altrimenti si finisce per appiattire i protagonisti rendendoli copie carbone di noi stessi. Non possiamo essere chiunque ed è giusto dare a ognuno il suo spessore, nel bene e nel male.
Il gameplay cambia per non cambiare affatto
Parlando di come si gioca, The Devil in Me segue la strada tracciata dai precedenti: ci sono le scelte da compiere in base alla bussola morale (ricordate che anche il silenzio vale) e quelle definitive che si affidano a cuore o testa per determinare, molto spesso, la sorte dei personaggi coinvolti.
Si esplora tanto, tendenzialmente con il fine di conoscere i dintorni per non farsi cogliere impreparati e cercare i segreti utili a comprendere la storia: ricordiamoci che siamo giocatori onniscienti, sappiamo tutto di tutti, ma i nostri personaggi sono “limitati” da ciò che trovano.
Certo, si potrebbe discutere che non condividano tra loro alcune informazioni, quando si trovano, ma siamo onesti, a chi interessa sapere davvero l’identità di un serial killer quando quest’ultimo è sul piede di guerra per ucciderci? Se non sono informazioni rilevanti sul momento, tanto vale rimandare i consessi a quando si è al sicuro.
Va riconosciuto però il fatto che alcune scoperte vengono condivise e, anzi, arrivano a stabilire se certe situazioni accadono o meno, compresi eventuali conflitti interni alla troupe: un ulteriore tassello a favore della narrazione, che rende i personaggi un po’ più consapevoli di cosa sta accadendo e come possano agire. L’esplorazione è quindi utile sia a noi giocatori sia ai personaggi per motivi diversi.

I QTE sono sempre presenti, a diversi gradi di complessità che dipendono dal livello di difficoltà scelto a inizio partita: quello medio richiede discreti riflessi ma lascia un margine di azione accettabile per non mandare al creatore tutti nel giro di qualche QTE. Specie considerando che in alcuni casi basta fallirne uno per condannare il personaggio. Per fortuna, e anche questa è una dimostrazione di crescita rispetto al primo capitolo, è possibile selezionare la scena da rigiocare senza aver prima finito il gioco – che è barare ma torna utile se si vuole sapere subito come sarebbe andata se. A maggior ragione quando potrebbero essere coinvolte le immancabili premonizioni, in questo caso sotto forma di tavole anatomiche.
Da House of Ashes torna la telecamera a trecentosessanta gradi, che sostituisce le inquadrature fisse per un maggior grado di libertà e anche meno anticipazioni su eventuali jumpscare; questi ultimi sono per fortuna diluiti e in moltissimi casi d’effetto, riuscendo nel loro intento senza risultare fin troppo opprimenti.
La verà novita in termini di gameplay è la presenza di oggetti unici per i personaggi, il che si traduce in azioni che solo loro sono in grado di fare: Charles può forzare le serrature con il suo biglietto da visita o il fermacravatta, nonché farsi luce con l’accendino; Mark può raggiungere oggetti fuori portata usando il monopiede, oppure scattare fotografie e volendo farsi luce a sua volta; Erin ha un microfono direzionale, che non serve vi spieghi cosa fa, e un inalatore per tenere sotto controllo gli attacchi d’asma; Jamie può interagire con i quadri elettrici per ripristinare la corrente e farsi luce con la torcia elettrica; Kate infine ha con sé la sua pietra mistica, che la aiuta a calmarsi nelle situazioni di panico, e anche lei può contare su una fida fonte di illuminazione.

A dispetto dell’unicità di alcuni oggetti, mi sarebbe piaciuto che avessero più ruolo nel gameplay o che potessero essere utilizzati in scenari già visitati con altri personaggi; invece a ognuno il suo e, anche quando siamo in coppia, non troviamo mai modo di chiedere al PNG di fare qualcosa per noi usando il suo oggetto unico. Sono interazioni che vanno molto a compartimenti stagni e dopo un po’, o addirittura dopo un solo utilizzo, smettono di avere peso sul gameplay. Un peccato e un’occasione un po’ sprecata. A questo si aggiunge la scomodità della fotocamera di Mark, la cui visuale è limitata e non può girare a trecentosessanta gradi, rendendone l’utilizzo (non obbligatorio a meno che non vogliate il trofeo dedicato) inutilmente scomodo dato il continuo disattivarla e riattivarla per posizionare meglio il personaggio.
Vale inoltre la pena citare gli Oboli, monete sparse lungo tutto il corso del gioco e che siamo invitati a raccogliere per acquistare, nel menu principale, i diorami: si tratta dei modelli dei personaggi o di scene che sbloccheremo nel corso della partita, a patto di soddisfarne le condizioni. Tutto sommato è un’aggiunta apprezzabile, per quanto ininfluente, che spinge ulteriormente sulla rigiocabilità.
Per il resto l’esperienza rimane la stessa che abbiamo imparato a conoscere, in positivo e negativo: la telecamera non è molto a nostro favore negli spazi ristretti e i personaggi a volte impiegano un attimo di troppo a reagire agli input, quasi siano “incollati” al terreno, o tengono troppo in memoria quello precedente creando un conflitto su dove devono muoversi esattamente.
In termini di interazione con l’ambiente, invece, c’è un po’ più di dinamicità: si striscia, ci si arrampica, si salta e si spostano oggetti con più frequenza rispetto al passato, senza contare le diramazioni che ci portano a scoprire qualche segreto aggiuntivo. Considerato l’alone di mistero che circonda il Castello della Morte, esplorare risulta molto più accattivante.
Comparto tecnico e artistico
Nulla da dire per quanto riguarda la realizzazione in sé degli ambienti.
Il Castello della Morte è curato nei dettagli, da quelli più raffinati ad altri macabri, e ho molto apprezzato la resa articolata dell’edificio con i suoi trucchi e passaggi segreti. Senza contare l’esterno e in generale tutte le parti aggiuntive che a una prima occhiata restano, giustamente, nascoste.
Inquietanti, nonché malate, al punto giusto le vittime che incontriamo e rispecchiano sia il sadismo dell’assassino sia la sua follia lucida: c’è metodo nelle sue azioni e saperlo concorre a renderlo più terribile di quanto non sarebbe se corresse per i corridoi armato di accetta.
La sua presenza è misurata, come lo è la sua voce che non sentiamo mai, e i giochi di luce lo rendono ancora più minaccioso. L’isola in sé su cui poggia il Castello è se vogliamo banale, confrontata a quest’ultimo, ma ho trovato la sua anonimità azzeccata e in linea con l’atmosfera: il vero protagonista, del resto, è l’edificio in sé.
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, infine, si notano i piccoli passi avanti soprattutto nel mocap dei personaggi e nella già citata assenza di uncanny valley. C’è ancora qualche piccola incertezza dovuta, quando si gioca da soli, al multigiocatore e al senso di attesa che comporta nelle interazioni fra i personaggi ma è sicuramente molto meno sentita rispetto al capitolo precedente.
Ottima anche l’illuminazione, soprattutto in determinate azioni ma anche nell’enfatizzare le espressioni dei personaggi, a questo giro più curata tranne in qualche occasione (ad esempio il prologo).

Durante la mia partita ho incontrato alcuni bug minori ai quali però sembravano legarsene altri più gravi: nel caso specifico, a seguito di una mia scelta il gioco decideva deliberatamente di far compiere al personaggio l’azione opposta, uccidendo così il compagno. Per fortuna ho potuto rigiocarla ma sono serviti diversi tentativi di una sequenza piuttosto lunga che, data la sua pessima conclusione, potrebbe risultare molto frustrante. Il problema non era la scelta in sé bensì un precedente bug che non permetteva l’uso dell’oggetto unico del personaggio.
Una patch, magari anche quella D1, dovrebbe essere più che sufficiente a risolvere il problema.
Nulla da dire, infine, sul sound design. Sebbene personalmente sia un po’ avversa alle musiche che, nel loro essere angoscianti, anticipano una possibile situazione di pericolo, non posso negare che si sposino alla perfezione con l’atmosfera; altrettanto validi i suoni contestuali, che arricchiscono l’esperienza con della tensione aggiuntiva sempre gradita in questi casi.
Conclusioni
The Devil in Me è un ottimo finale di stagione per The Dark Pictures Anthology, che mette in scena un thriller-horror molto più avvincente (forse perché il vero orrore sta nella componente umana e non in in presunto sovrannaturale) e convincente sia nei dialoghi sia nelle interazioni fra i personaggi. Il gameplay resta sostanzialmente invariato, tranne che per l’aggiunta di oggetti unici la cui valorizzazione nell’economia di gioco è poco pervenuta: il loro utilizzo è raro e sempe legato al personaggio in uso, quando sarebbe stato interessante poter richiedere l’aiuto di eventuali PNG qualora possibile. La ricostruzione del Castello della Morte, in termini estetici e di atmosfera, è assolutamente riuscita e il personaggio di Holmes (del passato quanto del presente) ben reso. Nulla da dire sul comparto tecnico, che muove sempre piccoli ma sensibili passi avanti, ma la presenza di occasionali bug, a volte gravi, rischia di minare l’esperienza e costringere a riavviare la sequenza in corso – ragione per cui, assieme a una non pervenuta esaltazione delle nuove meccaniche, non raggiunge il voto pieno. Se avete apprezzato i precedenti, sarete senza dubbio soddisfatti anche da questo capitolo, che può tuttavia essere apprezzato persino da chi non è un appassionato delle precedenti storie.